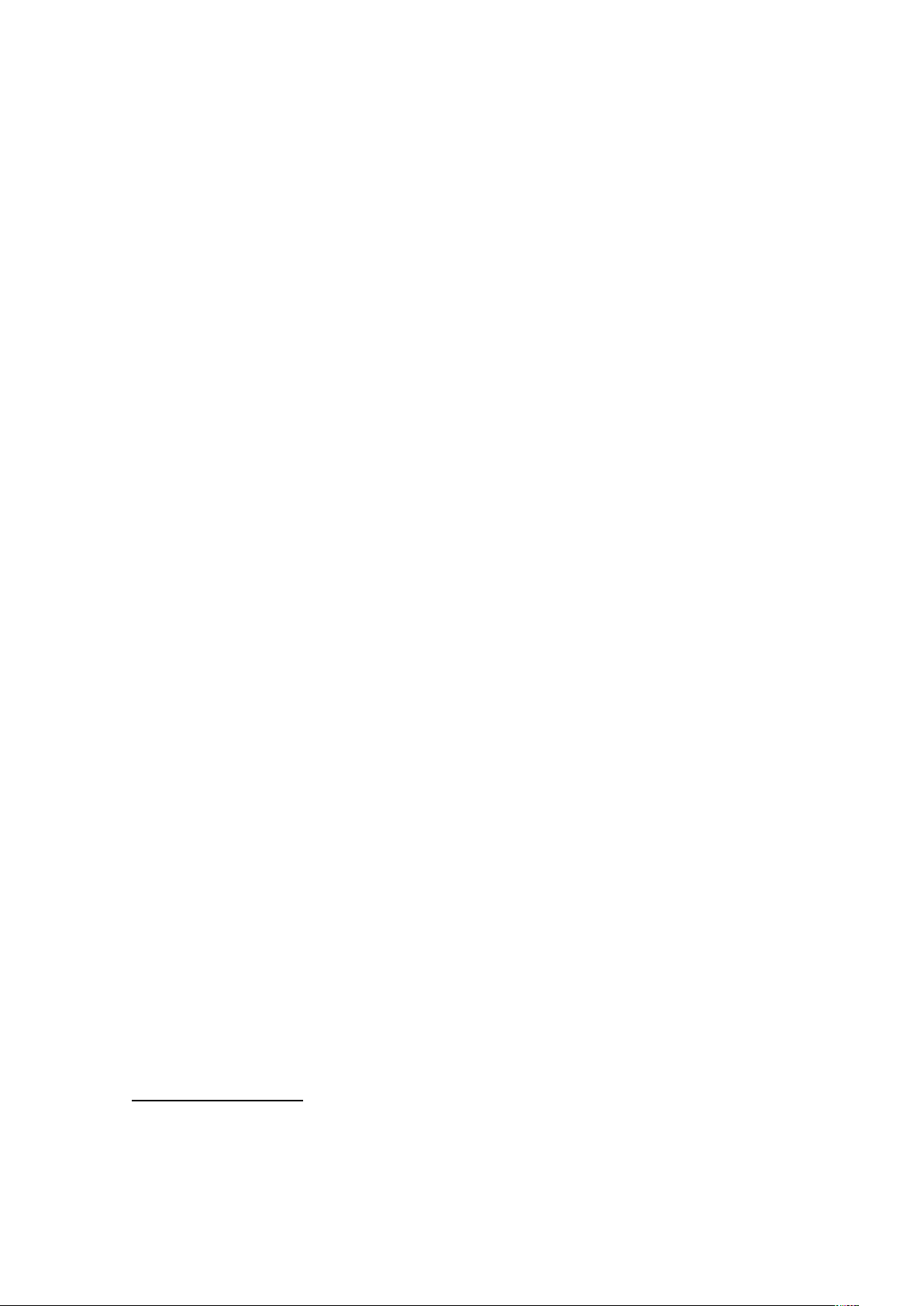






















Study with the several resources on Docsity

Earn points by helping other students or get them with a premium plan


Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity

Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
il reato fiore e fiandaca musco appunti
Typology: Study notes
1 / 28

This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!
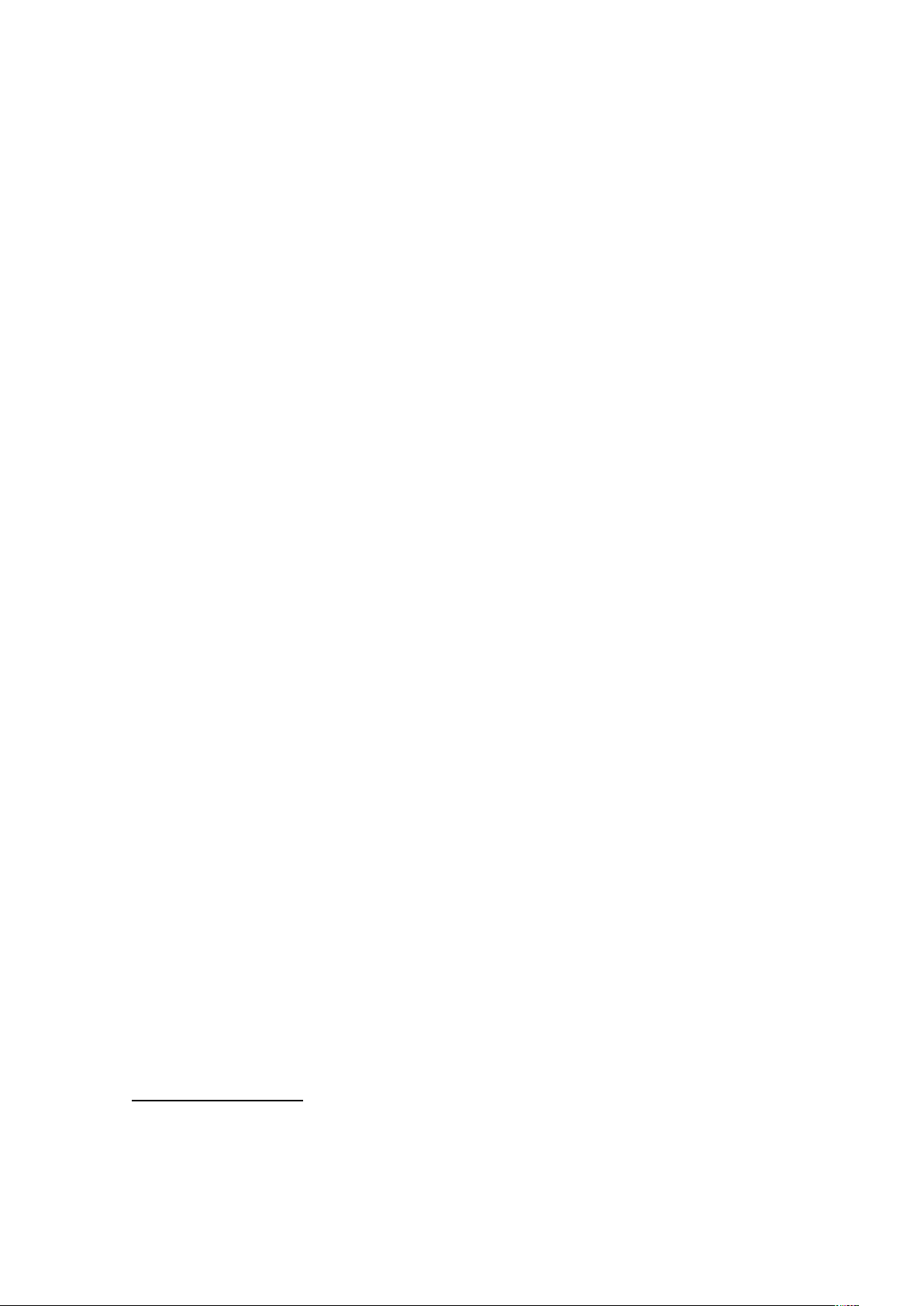




















1. Definizione di reato Al concetto di reato viene attribuito una definizione di natura giuridico – formale, secondo la quale è reato ogni fatto umano alla cui realizzazione la normativa attribuisce una sanzione penale. Tale definizione è stata delineata, esclusivamente, sulla base delle modalità con cui il nostro ordinamento reagisce nei confronti degli autori dei fatti incriminati, senza tener conto del reato nella sua sostanza. Suddetta esplicazione è da considerarsi corretta, e quindi può essere accolta, ma insufficiente in quanto nulla dice in merito ai fatti che costituiscono l’illecito penale, pertanto necessita di alcune precisazioni. Quest’ ultime possono essere fornite sulla base dei principi Costituzionali previsti esplicitamente per la materia penale, in virtù dei quali è possibile delineare gli elementi che caratterizzano l’illecito penale:
furto; appropriazione indebita; omicidio; ecc.). pertanto la scienza penalistica ha voluto elaborare una teoria generale del reato, con il fine di unificare tutti gli elementi comuni a tutte le tipologie delittuose. L’ elaborazione di una teoria generale del reato ha risposto sia ad esigenze logico – consecutive che ad esigenze di certezza giuridica^5. L’ obiettivo di tali teorie era quello di rinvenire un maggior numero di elementi comune alle fattispecie delittuose, ma detta esigenza ha indotto la dottrina ad elaborare e prospettare soluzioni artificiose pur di raggiungere l’unificazione concettuale. Si è verificato, in tal modo, un abuso di generalizzazione delle teorie generali del reato. Ciò ha indotto la dottrina ad affermare che le diverse tipologie di reato presentano elementi appiattiti all’ interno di una teorizzazione generale troppo onnicomprensiva per poter essere dotata di un reale contenuto conoscitivo. Tali limitazioni della teoria generale del reato hanno indotto la dottrina ad concludere che la suddetta teoria può essere ricostruita secondo differenti modelli di scomposizione analitica dell’illecito penale. E al contempo all’ elaborazione di diverse sotto-teorie generali destinate a sistematizzare gli elementi comuni ai diversi tipi delittuosi^6. Da sottolineare che il fulcro del reato è un fatto umano, il quale deve corrispondere alla fattispecie astratta descritta dalla norma, tale corrispondenza viene definita tipicità. Ma, non sempre un fatto tipico è contrario alle norme del nostro ordinamento giuridico, infatti esistono situazioni in cui è possibile porre in essere condotte penalmente punibili (es. legittima difesa). Per cui, affinché si realizzi un illecito penale è necessario che il fatto umano sia tipico e contrario ai dettami del nostro ordinamento, tale contrarietà è definita antigiuridicità. Altro elemento che contraddistingue l’illecito penale è la sua riconducibilità ad un dato soggetto, tale nesso è definito colpevolezza. In virtù di detta scomposizione operata dalla teoria tripartita, il reato può essere definito come un fatto umano tipico, antigiuridico e colpevole. Teoria, questa, molto sostenuta in dottrina, in (^5) In fatti in mancanza d categorie concettuali rigorose, il giudice non avrebbe punti di riferimento sicuri per orientare la decisione dei casi concreti secondo criteri di razionalità ed imparzialità. E’ anche vero tuttavia che, in sede di applicazione giudiziale, al richiamo delle categorie dogmatiche dee accompagnarsi la capacità di cogliere le articolarità del caso concreto: altrimenti, si ricadrebbe proprio in quell’ eccesso di concettualismo, dal quale soltanto con fatica la coltura penalistica contemporanea va via via liberandosi. Op. Cit. a pag. 3 (^6) Questo procedimento ha come esito la costruzione dogmatica “separata dei fondamentali modelli di illecito penale, nel senso che si distingue una dogmatica del reato doloso, una dogmatica del reato colposo. Op. cit. a pag. 3
quanto ritenuta idonea a soddisfare le esigenze di indagine del fenomeno giuridico che va sotto il nome di reato^7. Lo schema di analisi dell’illecito penale denominato concezione tripartita del reato è sorta in Germani agli inizi del Novecento ed è stata largamente dominante e condivisa anche in Italia. Tale concezione fonda il concetto dommatico del reato su basi normativo – valutative, con ciò si intende che gli elementi della costruzione vengono dedotti dai diversi livelli di collegamento che si stabiliscono tra il fatto penalmente rilevante e l’ordinamento giuridico, in questo modo si generano tante figure di qualificazione del fatto stesso. Secondo la concezione tripartita la prima, e più importante, figura di qualificazione del fatto penalmente rilevante riguarda la sua dimensione di conformità alla descrizione normativa del reato, denominata, appunto, tipicità. Però tale qualificazione da sola non è sufficiente a descrivere la struttura dell’illecito penale e non implica la contrarietà del fatto all’ ordinamento giuridico. Quindi, si necessita di un’ulteriore qualificazione del fatto che viene denominata antigiuridicità , con la quale, pertanto si indica la contrarietà del fatto all’ ordinamento giuridico. Ma, ciò non basta per descrivere il reato, si necessita di un’ulteriore qualificazione del fatto, che viene definita colpevolezza. Essa prende in esame tutti gli elementi che permettono di applicare una pena all’ autore del reato^8. Alla luce di ciò possiamo affermare che la teoria tripartita definisce il reato come un fatto umano, tipico, antigiuridico e colpevole, e che la tipicità, l’ antigiuridicità e la colpevolezza, costituiscono i tre elementi che, in una successione logico-sistematica, ogni reato deve possedere per poter essere considerato tale. I sostenitori di tale teoria (^7) Questa affermazione appare tanto più giustificata, quanto più si rifugga da approcci logico – formali astratti del tipo di quelli cari alla c.d. giurisprudenza dei concetti ( Begriffsjurisprudenz) e si privilegi, per contro, una prospettiva metodologica teleologicamente orientata: cioè incline a costruire le categorie dogmatiche tenendo conto della specifica funzione che esse devono assolvere all’ interno del settore giuridico consolidato. Op. cit. a pag. 3 (^8) Il contenuto di quest’ ultima categoria non appare, tuttavia definito in modo uniforme, nell’ambito della sua concezione tripartita. Originariamente ad essa, infatti, si assegnava il contenuto psichico dell’ azione (dolo e colpa); mentre, nell’ evoluzione della dottrina del reato, ci si è andati progressivamente orientando verso il superamento di questa concezione “psicologica” della colpevolezza, a favore di una concezione normativa di essa, nella cui prospettiva il giudizio di riprovevolezza dell’ agente dipende essenzialmente dalla verifica dei presupposti di maturità e normalità psichica ( da cui la legge fa dipendere l’ imputabilità del soggetto: art. 85 ss c.p.) e delle altre condizioni, normativamente richiesta per la rimproverabilità della condotta. Op. cit. pag. 3
In ordine al tema della scomposizione analitica del reato, oltre alla teoria tripartita, sono state elaborate altre teorie: 1) quadripartita; 3) bipartita; 4) unitaria. 1.3. Teoria quadripartita Un ulteriore passo verso la scomposizione del reato viene compiuta dalla teoria quadripartita o tetra partita, che arriva a scomporre il reato in quattro elementi, caratterizzata precisamente da due varianti. La prima distingue tra il fatto, la tipicità, ovvero la conformità del fatto alla fattispecie, l’antigiuridicità e la colpevolezza. La seconda, invece, individua il fatto, l’antigiuridicità del fatto, la colpevolezza e la punibilità, consistente nella meritevolezza di sanzione del fatto antigiuridico e colpevole. Le suddette teorie non hanno avuto grande seguito in dottrina, dovendo cedere di fronte alle stringenti critiche di quanti hanno osservato che, con riferimento alla prima variante, la tipicità non può assurgere ad elemento del reato, essendo il modo di essere dello stesso, e, con riferimento alla seconda, la punibilità è una conseguenza e non un elemento del reato, che consegue alla commissione del fatto criminoso, senza incidere sul relativo perfezionamento. Quindi, la sistematica quadripartita del reato individua in numero quattro gli elementi costitutivi del reato, ed in particolar modo individua:
Si precisa che la condotta e l’offesa sono presenti in qualsiasi fatto penalmente rilevanti, mentre gli altri elementi sono presenti solo in talune figure di reato. Gli elementi costitutivi del fatto sono espressamente previsti dalla norma incriminatrice. Gli elementi del fatto nella maggioranza dei casi sono individuati come elementi positivi, cioè come elementi la cui presenza nel caso concreto è necessaria per la sussistenza del fatto. A volte, la legge richiede l'assenza di una qualche situazione di fatto o giuridica e si parla in questo caso di elementi negativi del fatto. Per individuare gli elementi del fatto di reato il legislatore può fare uso dei concetti descrittivi perché il legislatore utilizza termini che fanno riferimento, descrivendoli, a oggetti della realtà fisica o psichica, suscettibili di essere accertati con i sensi o comunque attraverso l'esperienza. Oppure utilizza concetti normativi, ovvero il legislatore fa ricorso ad un concetto che fa riferimento ad una norma giuridica con la conseguenza che quell'elemento del reato può essere compreso soltanto sotto il presupposto logico della norma richiamata.
2.2 Teoria bipartita Per i sostenitori della teoria bipartita il reato è un fatto umano commesso con volontà colpevole che si compone di due elementi fondamentali:
consenso). Nel caso di assenza della situazione giustificante il fatto tipico sarà obiettivamente perfetto sussistendo anche l’elemento negativo costituito dalla “assenza di cause di giustificazione”. Rimane però il problema se il dolo debba investire, nella rappresentazione del soggetto, anche questo elemento negativo, cioè se il soggetto debba avere la consapevolezza anche della mancanza dell’esistenza delle situazioni giustificative. Sarebbe però arduo pretendere che il soggetto al momento della realizzazione del reato, possa estendere il suo esame conoscitivo a tutte le possibili situazioni giustificative, talvolta complesse da ritrovare. Quindi, tale dottrina scompone il reato in due soli elementi:
altri predicati che caratterizzano l’ illecito penale: antigiuridicità e colpevolezza^14. Quindi, è tipico il fatto che realizza tutti gli elementi essenziali richiesti dalla norma ad integrazione del reato. La conformità^15 alla fattispecie legale, cioè al fatto astrattamente ipotizzato dal legislatore, è ciò che consente di considerare un fatto concreto come reato. Pertanto, è reato ogni fatto perfettamente conforme al tipo legale, mentre la mancanza di anche uno solo degli elementi costitutivi di esso, esclude l'esistenza del reato (fatto atipico). In tale modo, la caratteristica in esame assolve la funzione garantista di indicare agli individui quali sono le condotte da porre in essere e quali, invece, da cui astenersi, al fine di non incorrere in una sanzione penale. Oltre ad assolvere tale funzione, il fatto tipico è chiamato anche a circoscrivere specifiche forme di aggressione ai beni penalmente tutelati. In questo modo si selezionano le forme o modalità di offese ritenute intollerabili dal legislatore al punto di giungere all’ applicazione della sanzione penale^16. Affinché il fatto tipico possa assolvere al meglio entrambe le funzioni è necessario che esso osservi tutte le esigenze poste dal principio di materialità, secondo il quale il fatto reato si deve manifestare in un contesto esteriore accertabile nella realtà fenomenica. Affinché ciò possa essere realizzato è necessario che il legislatore non crei tipi artificiali di reato, i quali non possono essere verificati nel concreto^17. 2.5 L’ antigiuridicità (^14) Solo l’ azione tipica può entrare nel campo dell’ illecito penale e risultare, quindi, suscettibile delle ulteriori qualificazioni (antigiuridicità e colpevolezza) da cui dipende l’ esistenza del reato e che presuppongono la conformità del fatto alla descrizione legale di un reato, vale a dire la sua tipicità. Op. cit. pag. 12 (^15) La conformità al tipo è il contrassegno caratteristico ed elementare del fatto penalmente rilevante; essa però non esaurisce la struttura dell’illecito penale, poiché, da sola, non implica necessariamente anche la contrarietà del fatto con l’ordinamento giuridico. Op. cit. a pag. 7 (^16) Se la norma da applicare al caso concreto non intende reprimere tutte le condotte comunque idonee a ledere il bene protetto, ma si limita a prevedere specifiche modalità di offesa al bene stesso, il giudice sarà tenuto a verificare se l’offesa è stata realizzata proprio con quelle particolari modalità legislative tipizzate: in caso contrario, in omaggio ai primi di legalità, tassatività e frammentarietà, il fatto (pur “sostanzialmente” offensivo) deve ritenersi privo di rilevanza penale. Op. cit. a pag. 3 (^17) Se l’illecito penale che viene in questione è privo di riferimenti empirici, perché non ha alla base alcun fenomeno delittuoso ben profilato nella realtà sociale, non solo è difficile ricostruire la precisa fisionomia, ma – ancor prima – il giudice non sarà in grado di accertare il “fatto materiale” il comportamento esteriore in cui il reato stesso dovrebbe concretizzarsi. Op. cit. a pag. 3
L'antigiuridicità è la contrarietà al diritto di un certo fatto, o, meglio, la contrarietà tra un fatto e la norma. Un certo comportamento, infatti, esteriormente può anche essere conforme ad una fattispecie di reato (ad esempio l'atto di uccidere un uomo corrisponde all'omicidio), ma occorre poi verificare se tale comportamento è contrario all'ordinamento giuridico o se esso non sia in qualche modo giustificato (così un conto è che l'uccisione sia avvenuta a scopo di rapina, un conto è che sia avvenuta a scopo di legittima difesa oppure che l'uccisore sia un poliziotto che spara nel corso di un conflitto a fuoco). La scoperta dell’antigiuridicità e la sua configurabilità come autonomo elemento costitutivo del reato comporta una duplice implicazione. In primis la differenziazione tra fatto ed antigiuridicità evidenzia la necessità di separare l’oggetto della valutazione dalla valutazione dell’oggetto. Tutto ciò determina una netta distinzione tra gli elementi descrittivi della fattispecie e gli elementi valutativi della stessa. Dall’ altro canto, l’introduzione del concetto di antigiuridicità, comporta la presa d’ atto che l’esistenza di una lesione di un bene giuridico, contraria al diritto obiettivo, è diversa dall’ esistenza dei presupposti per un’incolpevolezza. 18 Molti autori sostengono che l'istituto dell'antigiuridicità sia inutile perché si risolve, in sostanza, nel verificare di fronte ad un certo fatto l'assenza di cause di giustificazione; è quindi un giudizio di valore e un giudizio di valore non può far parte della struttura di un fatto. E’ di tutta evidenza infatti la contraddizione nell’affermare che l’antigiuridicità sia un elemento del reato, ma al tempo stesso affermare che esso sia un giudizio, da effettuarsi in seno all’intero ordinamento; un giudizio, infatti, è di per se qualcosa di esterno al reato, perchè è un’operazione effettuata dall’interprete. Né d’altronde convince, per la complessità, per non dire astrusità, quella teoria che vede l’antigiuridicità come un elemento negativo del fatto. L’antigiuridicità farebbe, cioè, parte integrante del fatto, ma in senso negativo nel senso che sarebbe un elemento (^18) Questa tesi era stata elaborata, in modo puntuale, da R. V. Jhering, per quanto attiene al diritto privato; ma l’idea dell’ antigiuridicità obiettiva, come autonomo momento costitutivo dell’ illecito penale, come è stato opportunamente ricordato anche di recente – era affiorata nettamente già nella dottrina di Feuerbach, il quale aveva appunto individuato, come ulteriore presupposto perché condotta umana costituisca reato, acanto alla esterna riconoscibilità dell’ azione lesiva, il difetto di una ragione giuridica, capace di qualificarla secondo una dimensione di conformità alle pretese dell’ ordinamento giuridico. Da Beling in poi, la moderna dottrina del reato esprimerà appunto l’idea dell’antigiuridicità, mediante il riferimento alla mancanza di cause di giustificazione. Op. cit. a pag. 7
contempla solo il dolo e la colpa, nonché il requisito della coscienza e volontà) ed è stato coniato dalla dottrina. Si tratta in pratica di un concetto processuale, indicante il soggetto che è stato giudicato colpevole del reato contestatogli, e che, col passare del tempo ha assunto un significato sostanziale. Tuttavia, nonostante la sua inesistenza a livello legislativo, quello della colpevolezza – secondo l’opinione più diffusa in dottrina - è da considerarsi ormai uno dei principi cardine di un moderno diritto penale; punire infatti un reato senza che ci sia volontà colpevole da parte del suo autore significherebbe imputare una mera responsabilità oggettiva, e abolire ogni finalità preventiva dall'irrogazione della pena. Mentre il diritto penale primitivo, non conoscendo il principio di colpevolezza, puniva gli eredi dei delinquenti, il clan familiare, ecc. Gli effetti che l’elaborazione di questo principio ha avuto sul codice penale attuale sono notevoli e occorre esaminarli per gradi. In particolar modo il principio di colpevolezza implica, in linea teorica che:
l’abbia voluto. Il legislatore del 1930 derogava al principio di colpevolezza anche nella responsabilità per concorso nel reato proprio; nell’imputazione oggettiva delle circostanze aggravanti; nella responsabilità del direttore per il reato commesso a mezzo stampa; nella punibilità cieca ed assoluta anche di coloro che non conoscevano il precetto penale (articolo 5). Con gli anni il legislatore, e la Corte Costituzionale hanno fatto giustizia di alcune ipotesi:
responsabilità penale è personale venne intesa solo come esclusione della responsabilità per fatto altrui^19 ; in un secondo tempo la Corte, per fugare il dubbio di incostituzionalità che si poneva per alcune figure di reati (in particolare le ipotesi di responsabilità del direttore di stampa periodica e della responsabilità del concorrente per il reato diverso da quello voluto) sostenne, in modo equivoco e sfuggente, che tra il fatto e l’evento ci voleva comunque un certo nesso psichico; senza però chiarire in cosa consistesse questo nesso psichico. In una terza fase^20 la Corte ha tratto dall’articolo 27 il corollario che il fatto, in tutti i suoi elementi, deve essere commesso almeno per colpa. 2.4. Il soggetto attivo del reato Il soggetto attivo del reato, od autore dello stesso, od anche reo, è colui che pone in essere la condotta descritta e punita dalla fattispecie incriminatrice astratta. La nozione di reo nel nostro ordinamento ha un significato sostanziale e non processuale, con ciò si intende che tale termine non indica la qualità di imputato o di condannato, ma con esso si indica la connessione che si instaura tra il soggetto agente e la condotta realizzata. Poiché il reato costituisce la violazione di un comando che lo Stato impone ai propri “sudditi”, esso può essere commesso solo esclusivamente dall’ uomo, il quale è dotato di capacità penale^21. Quest’ ultima è presupposta in tutti gli uomini, ma si differenzia in ogni singolo soggetto in forza dei requisiti che incidono sull’ idoneità ad essere destinatari di conseguenze penali. Pertanto si può parlare d differenti capacità penali: 1) capacità alla pena (imputabilità); 2) capacità alle misure di sicurezza (pericolosità sociale); 3) incapacità ad essere assoggettati alle conseguenze penali ( immunità). In relazione al soggetto attivo del reato è possibile distinguere i reati in^22 : a) Reati comuni, in cui l’autore può essere chiunque a prescindere dalla particolare qualità da parte del soggetto agente; (^19) la responsabilità oggettiva era ammessa, purché ci fosse nesso di causalità tra fatto ed evento (Corte Costituzionale, 107/1957 e 20/1971); (^20) a quale ha avuto inizio con la sentenza 364/1988, la quale è stata denominata da tutti come la “vittoria delle concezioni normative della colpevolezza. (^21) Quella attitudine a porre in essere azioni od omissioni penalmente rilevanti, indipendentemente dall’ età, sesso od altre condizioni generali. (^22) Op. cit. a pag. 2
b) Reati propri, in cui l’autore dell’illecito deve possedere una particolare qualifica affinché si realizzi la fattispecie incriminatrice astratta descritta dalla norma^23 ; quest’ ultima tipologia di reato si suddivide a sua volta in: